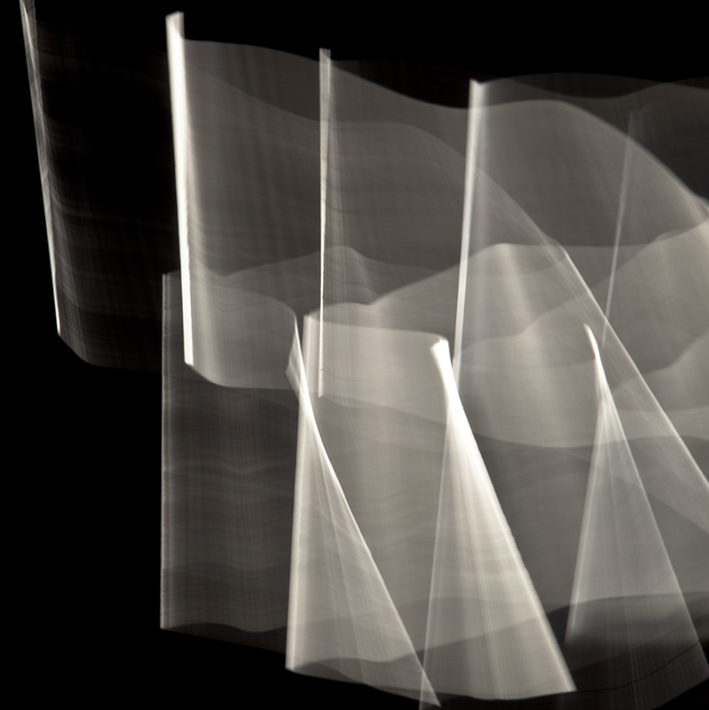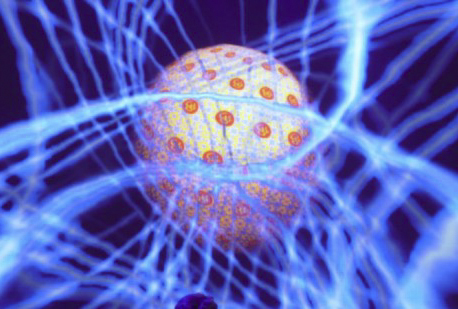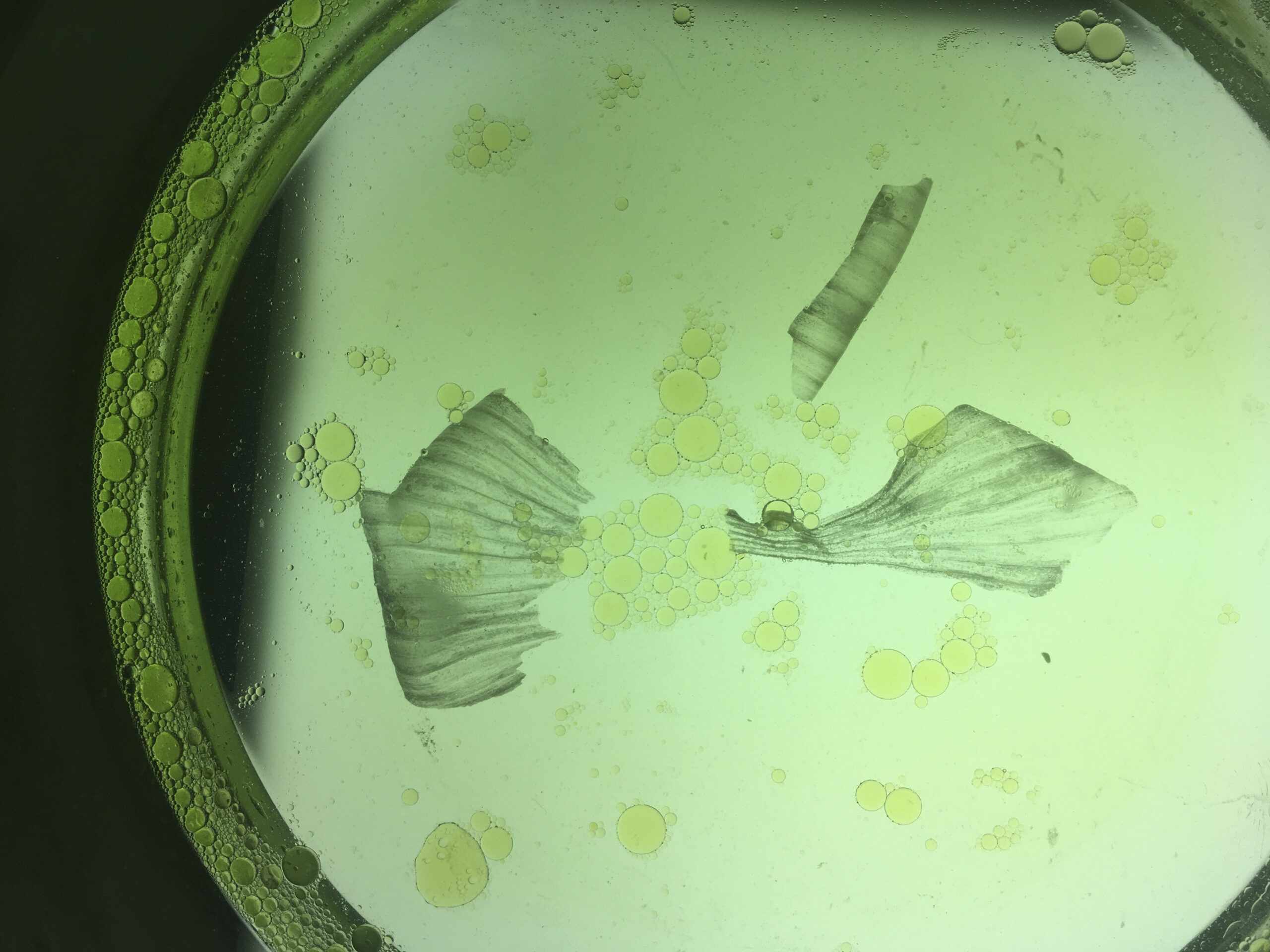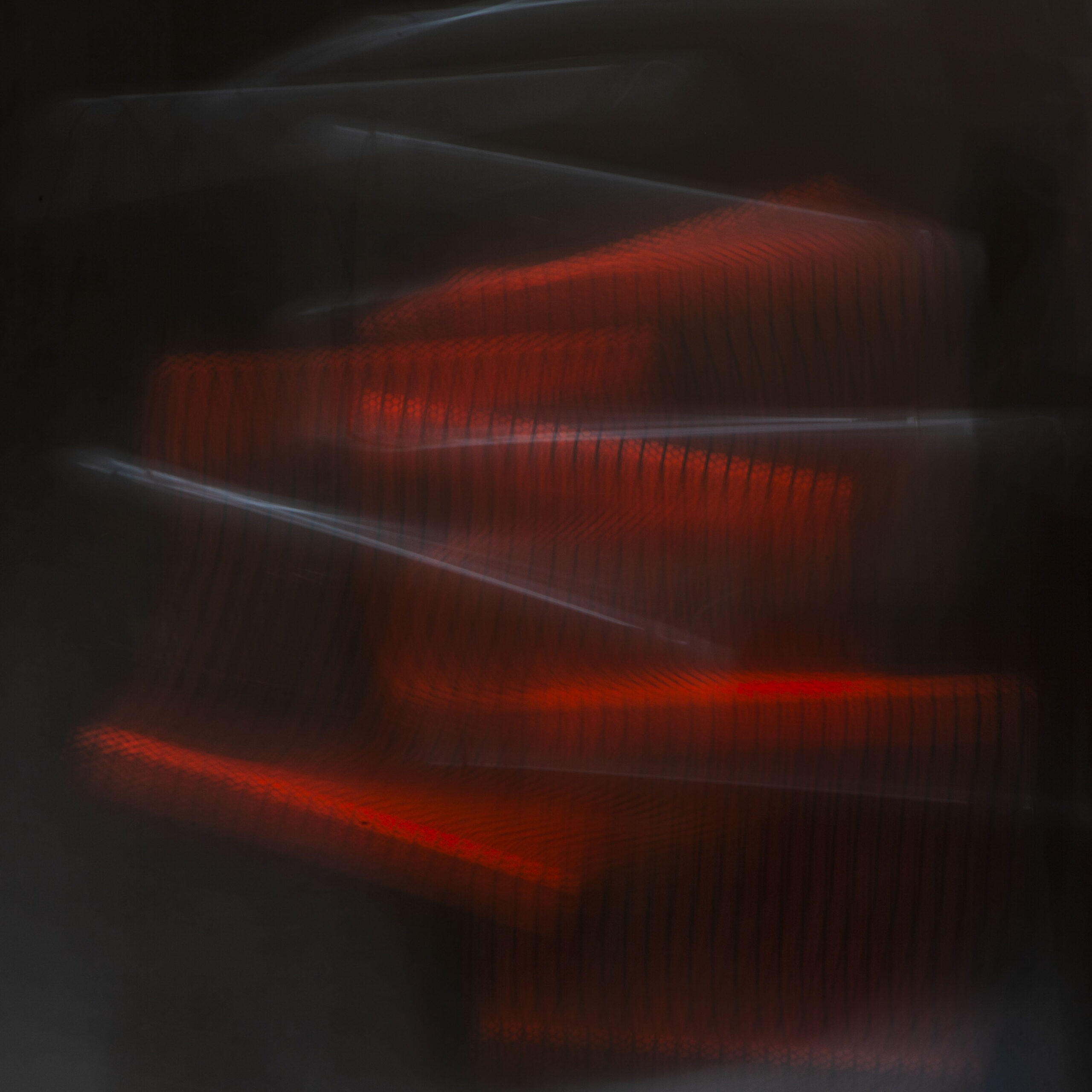“La Storia che c’è in noi” è un esperimento narrativo, un progetto che la nostra Associazione inaugura selezionando storie autobiografiche di vite “sospese” tra esperienze individuali e collettive.
Cerchiamo narrazioni che attraverso un vissuto personale riescano a documentare vicende sociali, eventi e vicende pubbliche che hanno influito sul pensiero comune, formandolo, deviandolo, condizionando i nostri rispettivi stili di vita e pensieri.
La Grande Storia, quella che viene raccolta e narrata nei libri, col suo fluire di eventi, genera infinite piccole storie.
Le infinite piccole storie che ne discendono sono il suo riflesso meno conosciuto e più interessante, perché l’incidenza degli eventi nella dimensione individuale induce chiunque a interpretarli e viverli secondo strategie e attitudini personali.
L’effetto prodotto dalla Grande Storia in ciascuna dimensione individuale è ciò che connota e rende originale ogni singola esistenza.
Ognuno di noi ha una Piccola Storia da raccontare: nell’attuale civiltà telematica essa è l’ultimo contributo davvero inedito e originale che possa arricchire la Grande Storia di ulteriori valori, ragioni, significati.
L’esperienza individuale e il punto di vista personale, rispetto a ogni grande storia, sono gli unici valori aggiunti in grado di conferirle vitalità ed evoluzione, sottraendola alla morte incombente della staticità documentaristica.
Nella giungla espressiva in cui tutto è stato detto, documentato, archiviato, riproposto, mistificato e revisionato, una lettura di certi eventi della Grande Storia attraverso la lente privata e intimistica degli individui è forse l’ultima frontiera editoriale e narrativa alla ricerca di un’originalità naturale,
del non detto e del realmente vissuto.
C’è chi si è lasciato trasportare dalla Storia e chi vi ha remato contro. Chi l’ha vissuta positivamente e chi l’ha subita passivamente.
C’è chi non l’ha capita, o chi l’ha soltanto scansata, restando da parte.
C’è infine chi ha vagato senza meta, tra convinzioni e fraintendimenti, adesioni e rifiuti, ipocrisie e verità,
in balìa di incertezze e visioni personali sino a creare un’altra storia, tutta propria.
Lo scrigno delle nostre vite private, rispetto alla Grande Storia, è una ricchezza da coltivare: conferisce centralità alla nostra esperienza.
Ci rende per una volta soggetti narranti della Grande Storia. Capovolge il rapporto tra la Storia e Noi.
*****
Luci da mondi paralleli.
(un racconto di Giuseppe Basile, 05/07/2009)
1.
Ragioni e Visioni
Ottobre 2008.
Diario di fine giornata. Ho appena chiuso le imposte. Ho attivato l’allarme. Mi guardo intorno, chiudo la porta e mi avvio per le scale.
Solita sequela di azioni e di gesti ordinari. Concludere la gestione della quotidiana routine. Tirare le somme. Cantare vittoria. Mettere in fila gli impegni del prossimo mattino. Programmare. Anche l’aria che si respira. Amministrare le energie. Evitarne l’inutile dispendio e riservarle al prosieguo: la giornata è finita, si torna a casa.
Sono in auto e con la mente non ho ancora staccato. Passo in rassegna tutte le cose fatte e non fatte, mi dedico a questo ripasso, una sorta di riepilogo quotidiano abitudinario e meccanico.
Come ogni giorno, penso che anche oggi le tensioni si sono susseguite con sistematica precisione, ma la concentrazione mi ha consentito di gestirle tutte, una dopo l’altra: dalle angosce lavorative, dalle scadenze dettate dalla successione rapida e vorticosa degli impegni, tutti da rispettare in tempi ristretti, sino alle preoccupazioni interiori, quelle immanenti procurate dai figli e dalle loro difficoltà, dalle turbolenze economiche e dalle incertezze sul futuro, dalle nostre indecisioni e da tutto ciò che mette a rischio la tenuta complessiva del “sistema”.
Come ogni giorno i pensieri si sono accavallati, intrecciati, offuscati, con la temporanea preminenza degli uni sugli altri, o con la loro caotica convivenza, senza vincitori nè vinti. Ma l’interferenza dei mille pensieri non ha fatto vacillare la mia concentrazione, l’ha solo temprata. E finchè il sistema regge, finchè la razionalità riesce a mantenere il controllo sull’emotività, le insicurezze, i timori, i danni concreti o astratti, ebbene, allora tutto è regolare.
Come ogni giorno. Tutto va, quindi tutto è ordinario.
L’energia che mi viene infusa dalle mie musiche magiche si unisce alla mia energia naturale, la sorregge, e forse in qualche modo, non so come, la accresce.
Potrò accumulare frustrazioni lavorative e personali, delusioni e amarezze, scontrarmi con la pochezza del prossimo e le nevrosi delle persone che mi circondano, con i comportamenti squallidi: dentro di me, però, so che c’è una sorta di rifugio tutto mio, un luogo in cui posso ritrovare slanci di poesia, emozioni. Vivo questo perenne entusiasmo alimentandolo continuamente e avverto il senso di tale mia appartenenza a questo mondo interiore governato dalla musica che mi tiene al riparo dal grigiore.
Ho appena terminato di relazionare il mio lavoro ai colleghi, sono trascorsi solo pochi secondi dacchè mi sono congedato da loro, tanto che la mente non si è ancora affrancata del tutto dai discorsi appena terminati, ma sto già volando, penso a Joni Mitchell e alla sua versione di “Woodstock” (il brano da lei composto e interpretato in modo sublime nel suo disco “Ladies Of The Canyon” del 1970), e così comincio a crogiolarmi nelle mie amate e continue riflessioni chiedendomi se in fondo preferisco quella sua versione originale o l’altra, apoteotica e più celebre, di Crosby, Stills, Nash & Young nel loro disco capolavoro “Deja Vù”, sempre del ‘70. Grande 1970. Onore al 1970. Ed ecco che la mia mente quasi obbedendo a un impulso automatico, parte a elencare i dischi capolavoro del 1970, come in una sorta di gioco a quiz televisivo. “Led Zeppelin III”, “Pearl” di Janis Joplin, “Starsailor” di Tim Buckley, “John Barleycorn” dei Traffic, eccetera eccetera.

Non tutti riescono a comprendere questo mondo. C’è chi non ne conosce minimamente i linguaggi, i contenuti, chi non è predisposto a recepirne i valori artistici e dunque non potrà cogliere nulla di eroico. Ma esiste anche un circolo di fortunati, di eletti, capaci di ricevere gli influssi benèfici di questa spiritualità espressa con le parole e i suoni della musica.
Non è un’area di svago consolatoria, un alibi o un luogo fittizio creato artificiosamente in noi stessi. E’ vibrazione, è passione, dedizione. L’appartenenza a questa dimensione sonoro-mentale produce una certa ebbrezza. In qualche modo, insomma, non so come, mi aiuta.
Inconsapevolmente questo beneficio lo percepivo e ricercavo già da bambino.
* * * *
 E’ il 1967 ed io ho appena un anno e mezzo. Mia sorella, sedici anni più grande di me, consegue la maturità scientifica a pieni voti, vince una borsa di studio della durata di un intero anno negli Stati Uniti e di colpo scompare dalla mia casa. Faccio fatica a capirlo, la rivedrò esattamente un anno dopo e durante la sua assenza non avrò occasione neppure di sentire la sua voce: il mondo, già “moderno”, è tuttavia ancora lontano dalla tecnologia diffusa della comunicazione di massa, esiste certamente il telefono, ma non per collegare Seattle con Taranto in modo agevole, rapido ed economico. La telefonata intercontinentale non è ancora alla portata di tutti. Il mezzo di comunicazione principe, dunque, resta ancora la tradizionale e romantica lettera, con i francobolli “posta aerea” : un mezzo incomprensibile e inaccessibile per i miei due anni di vita.
E’ il 1967 ed io ho appena un anno e mezzo. Mia sorella, sedici anni più grande di me, consegue la maturità scientifica a pieni voti, vince una borsa di studio della durata di un intero anno negli Stati Uniti e di colpo scompare dalla mia casa. Faccio fatica a capirlo, la rivedrò esattamente un anno dopo e durante la sua assenza non avrò occasione neppure di sentire la sua voce: il mondo, già “moderno”, è tuttavia ancora lontano dalla tecnologia diffusa della comunicazione di massa, esiste certamente il telefono, ma non per collegare Seattle con Taranto in modo agevole, rapido ed economico. La telefonata intercontinentale non è ancora alla portata di tutti. Il mezzo di comunicazione principe, dunque, resta ancora la tradizionale e romantica lettera, con i francobolli “posta aerea” : un mezzo incomprensibile e inaccessibile per i miei due anni di vita.
Mi ritrovo, dunque, nella mia casa in attesa di capire il motivo della sua assenza. Un giorno entro in una boutique della mia città, con mia madre: è un luogo che conosco, mia sorella ci andava spesso. Improvvisamente mi faccio l’idea che lei forse si è nascosta lì, la comincio a cercare, chiamandola, spostando i lunghi vestiti appesi alle grucce, frugando fra tutti quei capi esposti e ammassati sugli espositori. Ma è questione di poco. Tra qualche mese tornerà.
Nell’estate del 1968, finalmente, la mia sorella americana fa ritorno a casa. Ha appena vissuto un’esperienza straordinaria, specie per quei tempi. E’ stata ospite per tutto l’anno trascorso di una famiglia americana, “una famiglia tradizionale”, racconterà in seguito. “La sera, dopo cena, ascoltavamo dei dischi di musica classica”.
Seattle nel 1968 doveva essere distante anni luce dalla San Francisco della Peace & Love, dalla controcultura hippie e dai tumulti politico-sociali contro il Vietnam, eppure qualcosa, forse anche solo l’aria, il profumo di quegli anni, in qualche modo doveva essersi propagato sino alla porta della mia casa di provincia e borghese, in quella Taranto industriale e impiegatizia del Sud Italia.
Nonostante la mia tenera età, già avevo una discreta passione per i dischi 45 giri. Non mi separavo mai dal mio mangiadischi che portavo con me ovunque, anche a passeggio. Mia sorella, quando rientrò dagli Stati Uniti, portò con sé dei dischi americani che andarono a incrementare il nostro patrimonio discografico di famiglia, con mio enorme piacere: ma un giorno, per posta, lo ricordo bene, ne arrivarono altri.
Le erano stati spediti da amici, ragazzi della scuola che lei aveva frequentato. Ricordo perfettamente (perché li conservo ancora) alcuni 45 giri dei Credence Clearwater Revival (tra cui “Travelin’ Band”), ricordo l’LP dei Blood Sweat & Tears color legno, quello che conteneva “Spinning Wheel”, brano che successivamente acquistammo anche nella versione italiana di Niemen (“24 ore spese bene con amore”), anche se poi divenne più celebre un’altra versione cantata da Maurizio Arcieri.
C’erano un paio di 45 giri di Jimi Hendrix (“Let Me Light Your Fire”), ma il disco che più di ogni altro fece breccia nelle mie fantasie di bambino fu un 45 giri rosso, con l’etichetta della Columbia: era un disco dei Chicago. Il brano principale era la mitica “Does Anybody Really Knows What Time It Is”, con il suo tripudio di fiati jazzistici, brano di cui mi innamorai: la folgorazione, però, mi fu trasmessa dal lato B. Il brano era “Listen”, che io credevo fosse quello principale (considerando “Does Anybody”, al contrario, il brano inferiore).
La mia passione infantile per i dischi registrò una brusca e immediata accelerazione. Ascoltavo “Listen” centinaia di volte, ballavo sino allo sfinimento, sudavo, impazzivo per quelle trombe travolgenti, per il crescendo. Adoravo la voce del cantante, con quello stile così tipico per quegli anni, e poi quell’assolo di chitarra, ubriacante, alla Hendrix, su quella base ritmica corposa, calda, trascinante. Era il brano della mia vita.
Avevo cinque anni, era il 1971.
L’infatuazione per i Chicago crebbe un paio d’anni dopo, quando uscì un altro 45 giri mozzafiato: era “Lowdown”, con l’etichetta arancione: questa volta il confronto con la B Side era più immediato: “Loneliness Just A Word” era un brano troppo difficile, meno accessibile e non poteva reggere il paragone con la godibilità travolgente del lato A. Per me quel disco rappresentò l’apoteosi delle mie fantasie musicali di bambino, e fu l’unico 45 giri che riuscì per qualche tempo a farmi accantonare “Listen”.
Eravamo pieni di musica americana in casa: mio fratello, in particolare, prediligeva funky e rhythm and blues, aveva degli LP di Wilson Pickett, Joe Tex e James Brown (il suo idolo). Erano dischi che mi divertivano.
 Mia sorella aveva una cultura più ampia e una discografia più vasta, tendeva alla musica classica, ai compositori americani accademici (tipo Burt Bacharach), adorava l’ LP “Bridge Over Troubled Water” di Simon & Garfunkel , ma coltivava anche la grande musica italiana di quegli anni, Mina e Battisti su tutti.
Mia sorella aveva una cultura più ampia e una discografia più vasta, tendeva alla musica classica, ai compositori americani accademici (tipo Burt Bacharach), adorava l’ LP “Bridge Over Troubled Water” di Simon & Garfunkel , ma coltivava anche la grande musica italiana di quegli anni, Mina e Battisti su tutti.
Dal 1969 in avanti, almeno per qualche anno, la nostra affettuosa e distinta famiglia si ritrovò di tanto in tanto invasa da hippies, amici americani con cui mia sorella aveva mantenuto qualche rapporto epistolare, o che semplicemente conservavano il suo indirizzo. Bussavano alla porta all’improvviso, noi li ospitavamo sempre, con gli zaini e i sacchi a pelo. Cucinavamo loro cibo italiano e li portavamo in giro. Si accampavano nella mia cameretta dei giocattoli e io li guardavo con simpatia e ammirazione.
Fu un periodo breve, mia sorella si sposò molto presto e quindi andò via da casa nostra, come pure mio fratello: restammo soli in casa, mia madre vedova ed io. Non vidi più gli hippies, e quell’allegro viavai di personaggi curiosi e variopinti restò nel patrimonio della mia immaginazione e dei ricordi. Cominciai a coltivare da solo la mia passione per la musica. Una passione profonda. Non desideravo altro che 45 giri, costavano 800 lire, poi aumentarono a 1000 lire, ne compravo in quantità e li ascoltavo migliaia di volte, li conoscevo a memoria, anche se ancora non sapevo leggere i loro titoli in inglese. Riuscivo sempre a distinguerli, anche quando avevano la stessa etichetta ed erano dello stesso gruppo o artista.
Dopo l’uscita di casa dei miei fratelli, però, purtroppo, non avevo più nessuno che potesse indirizzarmi su quei generi musicali. La musica americana sparì dalla mia casa e per molti anni anche dalle mie conoscenze. La riscoprii, e ripresi a coltivarla, verso i 18–20 anni, quando ero all’Università di Bologna, nel nord Italia dove poi sono rimasto a vivere.
Era all’incirca l’85-86. Entravo nei negozi di dischi di Bologna, Firenze, Milano con particolare frequenza: tra i vari nomi che andavo sempre a controllare c’erano ancora i Chicago, ma per l’industria discografica non era il momento di pensare alle ristampe. Eravamo all’avvento del compact disc, la produzione era tumultuosa e sterminata, per lo più orientata verso il pop più moderno e commerciale di quegli anni.
La “nuova ondata” di artisti produceva nuove sonorità e una nuova estetica che lasciava ben poco spazio alle operazioni archeologiche e alla nostalgia. Sembrava, anzi, che dei vecchi artisti ci si dovesse sbarazzare quanto prima, per voltare pagina definitivamente. Le uniche compilations dei Chicago che mi capitava di vedere erano quelle su cui campeggiava la loro melensa (e miliardaria) “If You Leave Me Now”, una ballata nello stile Bee Gees: non era di certo un brano capace di infondere in me “energia” : energia vitale, energia creativa, come quella di “Listen” e “Lowdown” .
“Listen” , in particolare, l’ho scoperto poi da adulto, era contenuto in uno dei dischi più celebri di fine anni 60: “Chicago Transit Authority” del 1969 (ristampato dalla Rhino solo nel 2002), disco d’esordio dei Chicago passato alla storia per la sua assoluta libertà e fusione di stili e forme espressive. Oggi sono in grado di comprenderne i motivi, ma da bambino, quando non disponevo di un senso critico razionale e di una conoscenza artistica, quella libertà e fusione di stili e forme potevo percepirla solo in modo istintivo, attraverso una sollecitazione dei miei neuroni, a seguito di un ascolto avvenuto in modo del tutto casuale. Nessuno mi aveva detto e spiegato che cosa quella musica volesse dire: eppure era riuscita a condurmi in uno stato di ebbrezza, mi dava la carica, mi comunicava energia, e soprattutto, mi comunicava un senso superiore di libertà, una libertà vissuta ad un livello diverso che mi consentiva di muovermi scompostamente elaborando passi di ballo persino goffi e irripetibili, di dimenarmi in preda a un’estasi sonora, in una dimensione comportamentale differente, liberatoria.
* * * *
Estate 1995.
La mia vita universitaria è ormai finita da un pezzo, più precisamente già da sei anni. Mi avvicino ai 30 anni, e con essi, all’apoteosi dell’esistenza normalizzata. L’unica energia alternativa di cui continuo a sentire gli influssi è quella indotta dalla mia passione musicale, sempre immanente, sempre ingombrante. Interferisce con i miei studi da avvocato, con le mie necessità di sistemazione. E’ una molestia, una violenza carnale continuata e aggravata, anzi, attenuata (dal consenso della vittima).
Grazie a quell’energia, continuo a coltivare un mio mondo parallelo invisibile che mi aiuta a percorrere la strada ordinaria del quotidiano.
La razionalità, in ogni caso, ormai prevale, e anche la mia curiosità musicale, la mia sete di conoscenza la vivo in un altro modo. E’ una passione adulta, mi piace sempre ascoltare, ma sono pure attratto dalla lettura critica: la musica la voglio interpretare, capire, voglio studiarne la genesi, l’evoluzione.

Starship, Viaggio nella cultura psichedelica (Franco Bolelli, Castelvecchi, 1995. ISBN 88-86232-31-4)
Nel luglio-agosto del 1995 mi capita di leggere Un lungo articolo – dossier documentaristico sul numero 10 del mensile “JAM –VIAGGIO NELLA MUSICA”, rivista-culto, sebbene ancora agli esordi : “Starship, Viaggio nella psichedelìa” , a firma Franco Bolelli, Gianpaolo Giabini, Claudio Todesco, Luca Valtorta.
A colpirmi sono proprio le prime righe dell’articolo:
“Anni fa, quando era ancora alle elementari, mio figlio Daniele guardava un filmato con i Jefferson Airplane e il pubblico dei sixties californiani, e improvvisamente mi chiese: “perché non ci sono più in giro facce così?”. Ecco che cos’è la psichedelìa: quelle facce, facce aperte e luminose. Non “le cosiddette droghe”, né “fiori & colori” , né “il viaggio in India” . Psichedelìa non è uno stile, né una storia degli anni sessanta, psichedelìa è tutto quanto trasmette al nostro DNA un senso di espansione. E’ il contatto con una conoscenza luminosa, empatica, estatica, vitale. Sì, certo: Grateful Dead e Jefferson Airplane, Ken Kesey, acid tests e tutto il resto, irradiano il profumo irripetibile di quel luogo e di quell’epoca. Ma attenzione: il movimento psichedelico ha accarezzato una dimensione al di là del tempo (…). E’ l’intreccio fra correnti ancestrali e orizzonti evolutivi, è il grande gioco dell’energia, che la psichedelìa ha messo in scena”
Mentre proseguo nella lettura, avverto un immediato innalzamento della mia soglia di attenzione. Ho sempre cercato, infatti, di capire certe mie pulsioni verso quel tipo di musica, ma non ho mai trovato un testo in grado di spiegarmele criticamente. “Questo articolo forse parla di me”, penso. Quindi proseguo nella lettura, con lo stesso stupore di chi ha improvvisamente trovato un reperto archeologico, una mappa del0tesoro che ha cercato per anni.
“Dalla travolgente passione fra la psichedelìa e la musica è nato non un genere catalogabile ma una condizione atmosferica, una sostanza biochimica, una corrente d’energia. Prendiamo, naturalmente, i Grateful Dead. Perché i Dead possono indifferentemente slanciarsi negli spazi sonori più vertiginosi, tuffare le mani nel miele-&-marmellata del country, tramutare il bruco del rock in farfalla danzante? Perché si muovono non dentro i posti di blocco dei territori stilistici, ma un metro sopra. I Dead, Hendrix, gli Airplane, David Crosby, Tim Buckley, Syd Barrett, hanno riprogettato il DNA del suono, hanno espanso la chimica delle vibrazioni. Ogni molecola di suono (come ogni molecola dell’energia) vive di vita propria, è questa la semplice e miracolosa scoperta della psichedelìa (…). Ogni singola vibrazione libera così la propria energia, nuota nella grande corrente dell’evoluzione. Accade nelle chitarre liquide, negli slanci verso le atlantidi del suono, nei dolci rintocchi scampanellanti, nelle trances lunari, nei flussi tempestati da lampi magnetici. Tutti quegli “strani suoni” sono in verità l’essenza naturale del suono: solo che la percezione normalizzata è troppo rigida e ristretta per abbracciarli.
La psichedelìa ha preso per mano la musica e l’ha portata a perdersi per espandersi dentro un immaginario psicochimico, neurologico, filosofico, comportamentale, umano, infinitamente più ampio. Soprattutto, la psichedelìa ha coniugato la musica in una funzione tanto semplice quanto superiore: non una funzione estetica, né etica, né spettacolare, né d’avanguardia, tutte cose in fondo secondarie. Ma una funzione di vita. La musica psichedelica serve cioè a riscaldare i centri vitali, a rivitalizzare l’umore, ad espandere la consapevolezza, ad accendere la sensibilità percettiva, a suscitare energie di creazione.
Chi era quell’imbecille che disse “è solo rock ‘n’ roll” ?
Il servizio giornalistico su JAM era stato realizzato per illustrare una pubblicazione realizzata dall’Editore Castelvecchi : “STARSHIP, Viaggio nella cultura psichedelica”, a cura di Franco Bolelli, redattore anche dell’articolo. Mi affrettai, dunque ad acquistare questo libro che era uscito nell’aprile del ’95. Ciò che mi interessava comprendere era l’effetto della musica sui miei neuroni, e in particolare di quella musica.
Che cos’è che consente al folk, o al jazz, o alla musica classica, di contagiare persone diverse, esposte a sollecitazioni diverse, in luoghi tra loro culturalmente lontanissimi ?Quali sono i meccanismi per cui una data sonorità viene recepita da alcuni piuttosto che da altri, anche in un medesimo luogo? Il mio mondo musicale interiore, insomma, su che cosa si fonda? Su una mia proiezione fantastica, su una fantasia visionaria tutta mia, elaborata in modo autistico? Su un bisogno interiore di evasione dalla realtà? O su una sollecitazione esterna appositamente creata per produrre quegli effetti?
La lettura di “Starship” mi aiutò a comprendere, come mai mi era accaduto prima, il senso di quella musica e quella cultura. Pur attraverso frasi forse volutamente suggestive e retoriche, l’Autore riusciva a “spiegare” con una straordinaria capacità di sintesi, quella che costituiva la vera essenza di un messaggio culturale e di una esperienza umana e sociale che il tempo ha poi sminuito a “moda”, “costume”, “bizzarrìa d’epoca”, “stile”.
Io stesso, che pur riuscivo a ricavare molti significati, valori e grandi suggestioni dalla musica di fine ’60, sino ad allora avevo avuto la tendenza a etichettarla così come la cultura ufficiale me l’aveva illustrata e trasmessa: una sorta di visione, geniale sì, ma pur sempre estemporanea, un’elaborazione “artistica”, come la Bauhaus in architettura, l’impressionismo nella pittura, l’art-dèco nella moda, o il futurismo in letteratura.
Ciò che sino ad allora mi aveva stupito era il mistero per cui quel fenomeno, così diverso e per certi versi agli antipodi con i miei stili di vita, riuscisse a sollecitare la mia sensibilità: non solo quella artistica, ma quella umana. Ascoltare “Music Is Love”, “Tamalpais High (at About 3)”, e “Laughing”, dal disco “If I Could Only Remember My Name” di David Crosby del 1971 mi faceva sentire parte di un altro mondo, un mondo che, peraltro, io neppure conoscevo, di cui non ero parte, distante anni luce da me e dalla mia vita.
La lettura di quel libro, grazie anche alle sue citazioni introduttive, un po’ sloganistiche ma efficaci, mi fornì un’illuminante opportunità di comprensione:
“La psichedelìa non appartiene agli anni Sessanta. La psichedelìa accarezza l’essenza vitale e il senso evolutivo degli esseri umani.” .
“Una generazione perduta, dicono i predicatori del buon senso normalizzatore. Sciocchezze, credetemi. Semplicemente, per la prima volta un movimento ha scelto di proiettare la propria intelligenza, sensibilità, energia di creazione lontano dai poteri politici e culturali e dalla realizzazione nella storia e nel sociale. Ma questo movimento ha costruito mondi paralleli, ha irradiato flussi di deriva felice, è stato all’altezza non della sopravvivenza ma della vita”.
“Psichedelìa vuol dire droghe? No, niente affatto. Le sostanze psicotrope sono servite a porre certe domande. Ma le risposte stanno nel modello antropologico e nelle forme di vita che la psichedelìa ha messo al mondo”.
“I modelli mentali e neurologici “normali” ci offrono qualche scricchiolante resistenza ma più nessuna prospettiva” . “Mettere in causa un governo è ben poca cosa. E’ dall’intero mondo dell’esistenza normalizzata che è necessario liberarsi. Abbiamo oggi l’occasione straordinaria di reinventare l’intera grammatica comportamentale, l’intero nostro modo di vivere”.
“Abbiamo la possibilità evolutiva di liberarci dalla meccanica conformista che si è fissata nei nostri modi di esistere” . “Ormai nessuna evoluzione è più possibile a partire dal principio della necessità (dall’economia, dalla storia, dal sociale, dal pensiero critico)” . “Una nuova era antropologica, un nuovo slancio evolutivo, può nascere soltanto mettendo al centro la questione della felicità, l’esperienza della felicità”.
“Ma davvero pensate che cultura significhi pensiero concettuale, modernità, fronti aggrottate, logica critica e via tristeggiando? E’ veramente arrogante e patetico il tentativo della cultura intellettuale europea di accreditarsi come unica unità di misura”.
“La psichedelìa ha espresso il progetto culturale più avanzato della nostra epoca, la sola filosofia planetaria ed evolutiva”. “Non ha rinchiuso la vita nella gabbia del pensiero intellettuale. Al contrario, ha sciolto la filosofia nella corrente del vivere. Ha finalmente connesso la filosofia con il corpo, con il magico, con la natura, con il potere femminile di creazione, con la felicità”.
“Non c’è filosofia più profonda e più dolce di quella psichedelica. Perché la filosofia psichedelica non è pensiero intellettuale. E’ un castello di luce, una costellazione di sorrisi, una danza, un piano di volo, un assolo di chitarra, un surf sull’onda più alta, una carezza ai nostri neuroni e alla nostra vita”.
“Dalla conoscenza logica alla conoscenza luminosa: è questo il salto evolutivo che stiamo vivendo. La mente razionale e il modello dell’interpretazione critica stanno affondando nell’oceano della comunicazione pervasiva”.
“Conoscere per colpo di fulmine, per infiniti, per lampi, per brividi, per flussi, per innamoramenti”. “La conoscenza luminosa è la stessa delle piante e dell’energia nello spazio. La conoscenza luminosa coniuga la danza dei nostri neuroni con il ritmo dell’intelligenza globale della vita nell’universo”.
“Dove c’è il massimo di critica, lì c’è il minimo di creazione. Perché l’intelligenza critica ha impresso nei neuroni del genere umano l’abitudine a negare, non a mettere al mondo. Il pensiero critico è ormai evolutivamente impotente. Per il destino stesso degli esseri umani è necessario sintonizzarsi con una sensibilità di creazione”.
“La psichedelìa ha spostato l’accento dalla creatività alla creazione, dall’estro estetico all’energia estatica. Creazione è entrare in contatto con tutto il nostro potere vitale”.
“Non il denaro, né il possesso di simboli. Ma nemmeno il poverismo moralista. Si tratta di mettere a fuoco la ricchezza che gli esseri umani portano con sé: ricchezza è la consapevolezza dei giacimenti inestimabili e inesplorati che ci abitano, (…) è il sentimento che nella mente, nei sensi e nel cuore ci sono mondi di energie, di connessioni, di avventura che ancora aspettano di venire in luce”.
“Nessuno sforzo, nessuna ascesi è necessaria per vivere l’esperienza estatica, magica, psichedelica. Essa è semmai la naturale estensione delle nostre energie e dei nostri stati d’animo”.
“La realtà ordinaria, l’esistenza normalizzata è assenza di vita. L’esperienza estatica e psichedelica è essenza di vita”.
“Non contro le regole, ma al di là delle regole. Al di là dei ruoli, al di là del terreno della necessità, al di là dell’unità di misura del sistema-mondo normalizzato”.
“Qual è lo stile di vita psichedelico? L’ha detto Tim Robbins: stanchi di aspettare che il mondo migliori, vivere come se quel giorno fosse già qui”.
“Sesso-droga-rock & roll” è stata una formula superficiale che la vera esperienza psichedelica ha vissuto un metro sopra (…)”.
“La storia e il sociale appaiono grandi a chi soffre di miopia dell’immaginazione”.
“La musica, le immagini, gli eventi, i progetti psichedelici, non hanno una finalità estetica, né spettacolare, né etica, né culturale. Esprimono una funzione di vita: la funzione, semplice e superiore, di nutrire ed espandere i nostri centri vitali”.
“Tutte le ideologie, le religioni, le politiche, vogliono convincerti del loro mondo. La sensibilità psichedelica vuole convincerti del tuo mondo, della possibilità di dar vita a infiniti mondi singolari” .
“Se tutti i tentativi di cambiare il mondo falliscono miseramente, è perché non è quella la soluzione. La soluzione sarà moltiplicare i mondi. Trasfigurare dolcemente il mondo, perderlo in un caleidoscopio di mondi”.
“Fare mondi singolari, metterli in sintonia e in condivisione, al di là di ogni gerarchia, questa è democrazia non formale ma vitale. E’ politica psichedelica, politica evolutiva”.
“Come la Starship dei Jefferson (e dei Dead, di Crosby …) in Blows Against The Empire. Le migliori facce, anime, corpi, menti, che si liberano dal gioco assurdo del mondo normalizzato per volare fra spazi interiori e spazi cosmici, per aprirsi a un destino più grande, per sperimentare forme di vita espanse” .
“Più uguaglianza, continua a rivendicare la sinistra conformista. Senza vedere che al contrario la grande questione evolutiva è portare alla luce le infinite differenze singolari. Il limite della civiltà moderna è proprio l’esistenza di regole uguali per tutti mentre gli esseri umani sono diversi l’uno dall’altro. Non sono le diversità singolari a essere un problema, ma le gerarchie e il giudizio. Nessuna vera uguaglianza sarà mai possibile senza valorizzare l’irripetibile unicità dei singoli” .
“Fare mondi singolari non vuol dire arroccarsi in sé. E’ anzi la sola condizione per allestire comunità non difensive e consolatorie, ma capaci di valorizzare la ricchezza di ciascuno. Costruire sintonie elettive intorno alla più vasta molteplicità di punti di vista”.
“Se poi psichedelìa è un nome che non sentite vostro, bene, ci sono fortunatamente più esseri umani che sono psichedelici senza definirsi così, di quanti si dicono psichedelici senza esserlo davvero. Chiamate allora come più vi piace questa esperienza: ma innanzitutto, vi prego, vivetela”.
Fu la lettura di questo libro a trasformare tante mie sensazioni, in consapevolezze. La mia indole sognatrice, il mio fantasticare trovava per la prima volta una giustificazione : si, perché i comportamenti e gli impulsi più personali, quelli che non rientrano nella tipologie più comuni e riconoscibili, nel mondo conformato dalla razionalità necessitano di essere giustificati. La società borghese, poi, quella nella quale, peraltro, mi sono sempre anche riconosciuto, tende a farti sentire un cretino non solo quando balli scompostamente nella solitudine della tua stanza sudando sino a grondare sudore sul pavimento, ma persino quando magari parli “troppo spesso” di musica e “troppo poco” di politica, soldi, sesso o altri argomenti invece accettati come normali.
Cominciai a capire che il mio mondo era costituito da più mondi.
Non avevo bisogno di annegare nei fumi dell’alcool e dell’ L.S.D. per provare certi stati di ebbrezza. Né di perdermi per le strade senza meta dell’anticonformismo. Non rifiutavo nulla della mia indole borghese, né dei miei studi classici, e neppure del mio essere avvocato.
Per la prima volta capii che il mio patrimonio di neuroni contemplava anche una deriva irrazionale, un sogno fatto di colori indistinti, fatto di “arcobaleni psichedelici” , come dice Franco Bolelli.
* * * *
 Il volume “Starship. Viaggio nella cultura psichedelica” di Franco Bolelli si concludeva con un elenco di dischi fondamentali del genere. Alcuni li conoscevo già, ma tra gli assoluti, gli impedibili, me ne mancava uno: “Blows Against The Empire” dei Jefferson Starship, “il disco da portare con sé su un’isola deserta, nello spazio, in ogni casa, ovunque”, dice l’Autore.
Il volume “Starship. Viaggio nella cultura psichedelica” di Franco Bolelli si concludeva con un elenco di dischi fondamentali del genere. Alcuni li conoscevo già, ma tra gli assoluti, gli impedibili, me ne mancava uno: “Blows Against The Empire” dei Jefferson Starship, “il disco da portare con sé su un’isola deserta, nello spazio, in ogni casa, ovunque”, dice l’Autore.
Un pomeriggio scesi di casa, andai a comprarlo e rientrai subito per dedicarmi al suo ascolto.
Rimasi folgorato, mi girava la testa, un disco pazzesco, perfino troppo grande. “Have You Seen The Stars Tonite” mi comunicava delle sensazioni positive, mi faceva sognare in modo ottimistico. Cominciai presto a completare la mia discografia dei Jefferson, e non appena incappai nuovamente in “Somebody To Love”, che già conoscevo da bambino ma non ricordavo più, nel risentirla capii che quella musica era rimasta dentro di me, l’avevo inconsciamente conservata come un vago (ma prezioso) ricordo per tanti anni.
Provai un senso di commozione. Ripensai a mio padre che avevo perduto in quegli anni, alle atmosfere di sottofondo che accompagnavano la mia vita di bambino, all’aria che aleggiava in casa mia a quei tempi. Era bellissimo.
L’ascolto di “Blows Against The Empire” ha rappresentato per me l’esperienza musicale più emozionante della mia vita adulta. Ormai era chiaro che quel senso di felicità, di libertà, quella voglia di creare, anche se solo in una dimensione immaginaria incomunicabile, tutta mia, erano valori che avevo il diritto di coltivare. I Jefferson, pur nella mia consapevolezza di adulto, divennero come dei santi laici, i sacerdoti della mia fantasia, i gladiatori della mia immaginazione. Potevo far ricorso alla loro musica in ogni momento della mia giornata che richiedesse un dispendio speciale di energie fisiche o spirituali. C’è chi si affida alle religioni, chi ai mantra, alle concentrazioni mistiche o alle diavolerie pseudo mediche, ai talismani o agli influssi di stelle e pianeti. Io che pur snobbavo tutto ciò, constatavo che quelle sonorità, quei viaggi, mi conducevano in una dimensione di felicità e di positività, come “Listen” e “Lowdown” da bambino.
Con tutto il mio bagaglio di consapevolezze e tutte le mie tesi razionali e negazioniste di ogni genere di alchimia, decisi, dunque, di non abbandonare mai più quell’influsso benefico che non so per quali oscure ragioni si produceva dentro di me.
* * * *
Estate 1996.
 La vita spensierata e disinvolta degli anni universitari è ormai definitivamente archiviata tra i ricordi personali, e a quel senso di leggerezza si è sostituita la sensazione incombente, totalizzante, della gravità. La mia disoccupazione si protrae da alcuni anni e questo disagio contagia ogni cosa. E’ una non-vita, una sorta di non-essere. Avverto la drammaticità del momento, tento una via, anzi, le tento tutte.
La vita spensierata e disinvolta degli anni universitari è ormai definitivamente archiviata tra i ricordi personali, e a quel senso di leggerezza si è sostituita la sensazione incombente, totalizzante, della gravità. La mia disoccupazione si protrae da alcuni anni e questo disagio contagia ogni cosa. E’ una non-vita, una sorta di non-essere. Avverto la drammaticità del momento, tento una via, anzi, le tento tutte.
I concorsi pubblici si susseguono a buon ritmo e affido ad essi parte dei miei destini.
Dopo varie vicissitudini, un giorno, a sette anni dalla mia laurea ricevo una comunicazione importante: ho superato gli esami scritti di un prestigioso concorso in un’avvocatura pubblica di un ente istituzionale italiano. Bisogna andare a Roma a sostenere gli esami orali.
Mi siedo in macchina, da solo. Anzi, non da solo. Decido di portare con me, come sempre, un po’ di dischi.
Sono in autostrada, ripeto mentalmente alcuni argomenti delle prove orali, cerco di andare incontro a qualcosa di ineluttabile senza paura, senza insicurezze. Voglio affrontare la mia solitudine, la mia disoccupazione, il mio non-essere. Decido di vivere questa occasione nella più assoluta pienezza, le vado incontro con la tipica concentrazione di chi sa di essere, finalmente, alla resa dei conti, di fronte alla realtà concreta, quella che prima o poi deve necessariamente arrivare. Mi sento spettatore e artefice di questo incontro: è il mio momento, lo sento, la certezza mi proviene dalla mia sicurezza, dalla mia disposizione a viverlo nel modo più naturale possibile, senza esitazioni, dubbi, sensi di inadeguatezza, di colpa o di incoscienza. Mi sento presente, assolutamente presente. Devo solo concentrarmi nel modo giusto.
 Nel tratto autostradale fra Taranto e Bari accendo il lettore cd, inserisco “Have You Seen The Stars Tonite” e l’ascolto forse trenta, quaranta volte.
Nel tratto autostradale fra Taranto e Bari accendo il lettore cd, inserisco “Have You Seen The Stars Tonite” e l’ascolto forse trenta, quaranta volte.
Ho bisogno di trovare “il-mondo-tutto-mio”, quello che ho dentro. Questa volta voglio le stelle, le pretendo, le desidero, mi spettano. Le ho attese a lungo e saranno adesso tutte per me.
La disoccupazione è una brutta bestia, un cancro, un acido corrosivo della tua autostima, è qualcosa che lentamente riduce e consuma ogni spazio di vita, reprime ogni impulso. Questo mostro oggi è di fronte a me, per la sfida finale, ma la magia di “Blows Against The Empire” mi comunica una calma e una concentrazione superiore. Sono presente come non lo sono mai stato, ma in un modo che non so spiegare, so di essere anche altrove. Sono a un passo dalle stelle, le sento, e lì riverso tutti i miei sentimenti.
Arrivo al concorso, attendo il mio turno, sostengo gli esami orali con una calma serafica e soprannaturale che non è da me, riesco a comunicare tutto il mio equilibrio, la mia pacatezza, il mio essere all’altezza di quella prova: e finalmente, vinco. Conseguo così un importante lavoro che non cambierà la mia vita ma la stabilizzerà: poco dopo la mia ragazza diventerà mia moglie.
Da quel giorno farò di tutto per non inflazionare quegli influssi, per non abusarne, cercherò di ascoltare quel disco con minore frequenza, sempre e solo nei momenti che meritino davvero quelle grandezze siderali e quei voli.
* * * *
1998, gennaio.
Siamo appena sposati, da pochissimi mesi. I nostri rispettivi lavori ci dividono ora tra il Nord e il Sud dell’Italia (io a Modena, lei a Taranto), ma nonostante questa difficoltà logistica, è un buon momento, stiamo vivendo una fase fatta di nuove complicazioni, segno che siamo andati avanti, che c’è un’accelerazione del presente.
A noi, in realtà, il presente interessa solo nella misura in cui tenda al futuro, è solo una scala verso il futuro, un veicolo che cerchiamo di condurre lì, dove la nostra vita in comune inizierà davvero.
In un fine settimana mia moglie viene a trovarmi a Modena. Trascorriamo tre giorni insieme, siamo pieni di energia, di creazione. Sentiamo ancora una volta, nell’aria, l’ineluttabilità del momento. C’è qualcosa di inesorabile, di “scritto”, in certi giorni. Sembra che perfino la luce sia in qualche modo diversa.
In una serata silenziosa, mentre fuori la nebbia ovattata e il freddo emiliano sembrano voler isolare le nostre quattro mura disadorne dalla realtà esterna, decido di lasciar scorrere “Blows Against The Empire” per un po’. La nostra abitazione, al terzo piano di una palazzina senza ascensore avvolta da un silenzio spettrale di periferia, sembra aver perduto ogni contatto col mondo circostante. E’ un’astronave. Siamo fuori dall’orbita terrestre. Sospesi nel vuoto, chiusi nelle nostre quattro mura. Assolutamente soli e felici.
In casa c’è una luce calda, cuciniamo e beviamo allegramente nella nostra cucina nuova di zecca, appena consegnata e montata, profumata di cartoni da imballaggio e di legname ancora fresco di magazzino. I brani si ripetono, si susseguono. Quelle note country di “The Baby Tree” espandono le loro dolcezze e quelle atmosfere tanto semplici da apparire irreali si irradiano nella casa, mescolandosi con le luci gialle dei faretti e i profumi di cibo, di legno, di nebbie padane. Dopo pochi giorni sapremo che mia moglie è in attesa di due gemelli. E questa volta la vita cambierà davvero.

Jefferson Starship Galactic Reunion (Salò, 15.07.2005). Paul Kantner, Diana Mangano, David Freiberg. (Giuseppe Basile © Geophonìe)
Dovranno trascorrere ancora un po’ di anni prima di poter incontrare dal vivo i sacerdoti della mia fantasia, i gladiatori della mia immaginazione. Ma anche questo, prima o poi accadrà.
Dovrò attendere il 15 luglio 2005 per guardare negli occhi Paul Kantner, Diana Mangano, David Freiberg. A Salò, sul Lago di Garda, con Country Joe McDonald, e addirittura Tom Costanten dei Grateful Dead.
E poi l’1 e 2 dicembre del 2006 al Blue Note di Milano, con Marty Balin che suona per me “Coming Back To Me”, da solo, voce e chitarra, con un’esecuzione perfetta, intensa, profonda, da far accapponare la pelle.
Eccoli, i miei Jefferson Starship, fantastici. Ho ballato con loro, sul palco, in un’altra dimensione, oltre me stesso, oltre il mio “essere-avvocato-borghese-padredifamiglia”.
Attimi di felicità pura, “essenza di vita”, come dice Franco Bolelli.
2.
Arcobaleni di un’altra età.
Gennaio 2009.
Mi sono svegliato un po’ prima del solito. Ho dormito poco e male. Anche se potrei tentare di guadagnare gli ultimi minuti di riposo decido di arrendermi al nuovo mattino e di alzarmi.
Sto facendo colazione da solo, in silenzio. Le mie figlie dormono, mia moglie invece è già sveglia. Risponde lei al telefono che insolitamente squilla alle sette e un quarto. Si dirige in cucina, viene verso di me, mi consegna il telefono: “è tuo fratello”.
“Stanotte nostra madre ha avuto una grave crisi cardiaca. Non sono riusciti a salvarla”.
Si era appena ricoverata, non la conoscevano neppure.
Vivo a novecento chilometri di distanza. E’ morta senza di me. E’ accaduto di notte, tra le braccia di una dottoressa di turno notturno che cercava di rianimarla. Mi sento solo. Vorrei sentirmi solo come si è sentita lei, vorrei comprendere il dolore e la paura di morire da soli, senza lo sguardo dei propri figli, tra le braccia di un’estranea, tra pareti estranee, lontano dalle mura domestiche, dai propri arredi.
Vorrei comprendere quel dolore per condividerlo, come se condividerlo in qualche modo potesse alleviare il suo.
Trascorrono i minuti, mi rendo conto che è accaduto quello che per tutta la vita avevo sempre temuto, sin da quando ero bambino. E’ giunto il momento che nessuna persona al mondo vorrebbe mai che arrivasse. E’ come morire. Eppure sono vivo, sono qui, sono altrove. Sospeso nel vuoto.
Si è fermato il mondo, il tempo. E’ tempo di partire.
Affrontiamo un lungo viaggio, dal Nord al Sud, mia moglie, le mie figlie ed io. Sono lucido e presente, guido con i nervi saldi, ma cerco di interpretare il vuoto incolmabile che c’è in me, il vuoto in cui mi trovo.
E’ una sensazione che tende a svanire quando arrivo a Taranto, la mia città. Vengo risucchiato dagli eventi, dagli adempimenti. La sala mortuaria, i fiori, la folla dei conoscenti, l’andirivieni tra l’ospedale e la mia casa, e poi il viaggio rapido verso la chiesa, i funerali.
Occorre concentrazione. Voglio essere presente, voglio capire, voglio sentire esattamente tutto ciò che sto vivendo. Ho ancora i nervi saldi, ho sempre il vuoto dentro, ma non c’è tempo di capirlo. Dovrei restare solo per avvertirlo nella sua massima intensità, sarebbe l’unico modo per sentirmi vicino a quel baratro in cui lei è scivolata, per entrarci, per sentire che quel baratro esiste, e quindi esiste lei.
Quando sono arrivato in quell’ospedale ho realizzato che mia madre era morta in un luogo della nostra città che nessuno di noi aveva mai visto, neppure lei. Non eravamo mai stati lì. Il quartiere è degradato, c’è un grande piazzale incustodito. Istintivamente l’estraneità del luogo e le sensazioni di rifiuto verso di esso mi spingono a far sì che nulla di ciò che più intimamente mi appartiene possa restare lì. Non voglio lasciare la mia anima in preda a quei luoghi e a quell’insidiosa estraneità: prendo, dunque, tutti i miei dischi disseminati nell’auto, li chiudo in una busta di plastica e li porto con me.
Entro nella camera mortuaria con la busta in mano e vi trascorro alcune ore. Più volte sposto quella busta da una sedia all’altra, poi la ripongo su un tavolo, poi sotto una mensola, infine di nuovo sotto una sedia. Ho avuto paura che qualcuno, mentre ero intento a portare l’ultimo saluto a mia madre, potesse scassinare la mia auto, rubarla, con tutti i miei dischi al suo interno, ma provo anche un certo imbarazzo verso i presenti, non ho piacere che si chiedano cosa contenga quel pacco che porto con me e custodisco con tanta dedizione.
Questa esperienza mi trovo poi a riviverla anche nelle ore successive, al funerale. Arrivo nei pressi della chiesa ma parcheggio lontano, in una brutta strada. La busta è accanto al mio sedile, me la porto sino in chiesa, non me ne separo neppure in questo momento. La appoggio per terra, nell’inginocchiatoio del banco della prima fila e la tengo tra i piedi, tra le gambe, finchè mia figlia non si incarica di prenderla e tenerla con sé.
C’erano i dischi dei Jefferson Airplane dentro. C’era “The Baron Von Talbot and The Chrome Nun”, autografato da David Frieberg, “Blows Against The Empire”, autografato da Diana Mangano.
A tarda sera, rimasto finalmente solo, provo a compenetrarmi nel vuoto che avverto. Provo a immedesimarmi ancora una volta in quella musica, cerco un contatto, invoco le stelle come tante altre volte. Sento che non funziona. A un certo punto attraverso in auto dei luoghi cari alla mia vita e mi commuovo ascoltando “Harp Tree Lament” con quella sua coralità intensa che muove alla compassione, all’umana pietà, ma nella confusione emotiva, nel dolore, non riesco a ritrovare la mia antica sintonia con quelle composizioni.
Le giornate si susseguono come i pensieri, l’auto mi conduce sulle strade quotidiane dei miei impegni lavorativi e sono di nuovo a Modena, sempre solo in quell’abitacolo, in cerca di una musica che mi aiuti a interpretare il vuoto, a esplorare gli “interminati spazi” leopardiani, l’infinito e tutto il resto.
Finalmente, in un mattino di tiepida luce invernale, nella zavorra di dischi che mi porto dietro mi viene voglia di ascoltarne uno che conosco a memoria, “Blue Bell Knoll”, il capolavoro dei Cocteau Twins.
Avverto subito una certa sintonia coi pensieri e gli umori del momento. Quando arriva, però, il terzo brano, “Carolyn’s Fingers” provo qualcosa di più intenso. I suoi ritmi gelidi e ripetitivi sembrano una rappresentazione sonora del divenire, dell’evoluzione meccanicistica di un universo in movimento, geometrie incoscienti governate da una ragione muta su cui si innesta, come una sovrumana speranza, la voce eterea e inarrivabile di Elizabeth Fraser. I suoi gorgheggi sembrano perdersi nell’infinito, si propagano nel vuoto assoluto e trasmettono quell’amore universale che solo l’essere superiore femminile può riuscire a liberare e a espandere in un cosmo indifferente.
E’ la stessa umana compassione che altri artisti hanno espresso in altre forme, ma questa volta il viaggio oltre sé stessi avviene in una dimensione diversa:
Quello dei Jefferson Starship di “Blows Against The Empire” è un viaggio di umani, un’avventura vissuta da umani vivi e vegeti che nella sublimazione della propria essenza di vita terrena riescono perfino a proiettarsi in un’esperienza ultraterrena, a vivere il viaggio cosmico come avventura;
La voce di Elizabeth Fraser, al contrario, sembra provenire da un altro mondo, un’eco lontana nella quale tuttavia riusciamo a specchiarci, quel tanto che basta per sentire che una traccia dei nostri umani sentimenti permane nel tempo e nello spazio, e in qualche modo, chissà come, talvolta si ricongiunge a noi.
La musica dei Cocteau Twins ha qualcosa di extrasensoriale, riesce a interpretare altri mondi, altri schemi, altre dimensioni. Ascoltarla, a volte, è come intravedere un futuro per i nostri sentimenti, immaginarli al di là di noi stessi e della nostra fisicità, confidare in una pur minima forma di eternità.
Sento questa canzone, ora, ogni mattina. La voce di Elizabeth Fraser che sale in quegli spazi incommensurabili, vuoti e gelidi, è la metafora dei miei pensieri che si arrampicano sin lassù, si aggrappano a un altro mondo, tengono la presa per pochi istanti, e poi tornano giù nella vita reale, nell’unica dimensione che ci è dato conoscere e a cui per ora sentiamo di appartenere. Mi sembra a volte proprio di salire nello stesso modo in cui si eleva la sua voce, come rivoli e capriole di fumo che girano su sé stesse e in modo evanescente si espandono.
Riesco ad affacciarmi in un luogo immateriale, dove non mi pare di incontrare neppure gli elementi del buio o della luce. E’ un luogo in cui, per brevi momenti, mi pare di poterle dare il buon giorno, ogni mattina, di salutarla e potervi introdurre, come un granello di sabbia, il mio amore. Lo stesso amore che mi sembra di ricevere dalla voce soprannaturale di Elizabeth, forse un segno dell’universalità dei sentimenti. Forse.
Mi affido a questa sensazione flebile, alla vaga percezione della sua lontananza. E’ il mio modo di colmare il vuoto incolmabile per l’amore materno perduto.
****
Riapro le imposte, disattivo l’allarme. Illumino e arieggio le stanze.
La mia è la meno luminosa, ma rispetto alle camere degli altri colleghi ha il pregio di affacciarsi su un cortile interno silenzioso e rilassante.
E’ un piano rialzato, una porta-finestra mi consente di accedere al cortile scendendo due scalini. In realtà non ci vado mai, ma mi piace sapere di poterci andare.
Ogni tanto vedo passare dal centro del cortile dei gatti, qualcuno si ferma sotto l’albero di limoni che è lì al centro in un fazzoletto di terra mal curata. Ce n’è uno, invece, che si posiziona sugli scalini e resta lì, immobile, per ore e ore. A volte volge lo sguardo nel mio studio, altre volte invece guarda il cortile.
Quando apro le imposte è quasi sempre lì. Il suo sguardo è sempre imperscrutabile, immobile, non comunica alcuna sensazione. Eppure mi fa compagnia. Anche quando sembra un soprammobile di porcellana, freddo, inanimato.
Non mi ha mai dimostrato familiarità, anche se mi conosce benissimo. Né io ho mi sono mai adoperato per suscitarla. Nessuno potrebbe sostenere di ricevere beneficio da una presenza così indifferente. Ma a me piace così. Non gli chiedo nulla, non gli chiedo di essere diverso. Alla realtà ho imparato a contrapporre l’alternativa della mia fantasia.
 Giuseppe Basile, 05/07/2009.
Giuseppe Basile, 05/07/2009.
© Geophonìe. Diritti riservati.
(05/07/2009)