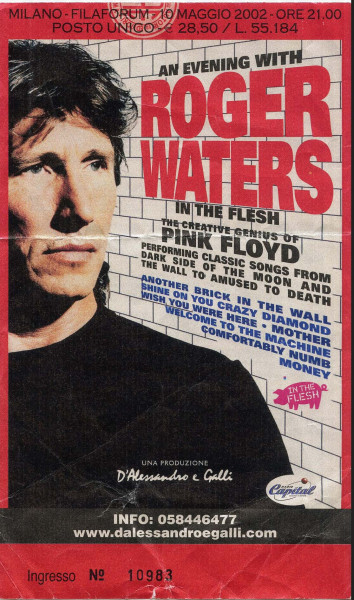 Non sono stati pochi quelli che inizialmente hanno storto il naso durante il concerto milanese di Roger Waters, ma col senno di poi avranno senz’altro riconosciuto di non aver compreso pienamente la performance. Siamo abituati a vedere i Pink Floyd calati in un palco gigantesco, dove i singoli musicisti quasi scompaiono. Nei concerti dei Pink Floyd sembra che sia una macchina a suonare, in una perfezione fredda e irreale. Anche i brani sembrano perdere la propria individualità, assomigliando ad un’unica sinfonia divisa in varie parti.
Non sono stati pochi quelli che inizialmente hanno storto il naso durante il concerto milanese di Roger Waters, ma col senno di poi avranno senz’altro riconosciuto di non aver compreso pienamente la performance. Siamo abituati a vedere i Pink Floyd calati in un palco gigantesco, dove i singoli musicisti quasi scompaiono. Nei concerti dei Pink Floyd sembra che sia una macchina a suonare, in una perfezione fredda e irreale. Anche i brani sembrano perdere la propria individualità, assomigliando ad un’unica sinfonia divisa in varie parti.
Il concerto di Waters sulle prime ci ha spiazzato perché è stato concepito in modo diverso. L’assenza di tecnologie e strutture sceniche elefantiache rende necessaria la presenza di un front man vero, diversamente dai concerti del gruppo, in cui la presenza di Gilmour era molto discreta, e in certi momenti appariva persino non necessaria: protagonista era soltanto la musica, nella perfezione assoluta delle sonorità, accompagnata da quelle scenografie grandiose che contribuivano a realizzare quel senso di “musica siderale” tipico del gruppo.
Lo show di Roger Waters non poteva ricalcare questi schemi. Waters voleva ripercorrere la sua carriera interpretando (anche) il periodo dei Pink Floyd nella “forma canzone”, come in un recital. Quando è entrato sul palco ed è salito sul corridoio rialzato alle spalle degli strumentisti abbiamo visto un musicista che senza tanti fronzoli estetici e scenografici, in fondo ridotti al minimo indispensabile, ma pur sempre suggestivi, sembrava volesse dire: “ho diritto anch’io di cantare le mie canzoni”. E nel far questo lo faceva calandosi nel ruolo inevitabile e inedito di front man del palco, forse anche con un certo imbarazzo, ma comunque in modo onesto, con semplicità e serenità.
Il concerto, quindi, ha preso una piega diversa da quella che ciascuno di noi immaginava. E’ stato un concerto suonato da umani, non da macchine governate da musicisti invisibili e imperturbabili. E in questo aspetto il concerto ha trovato la sua unicità.
Waters sulle prime appare persino un po’ goffo nel dover fare qualche “mossa” da palco – alla Jimmy Page e Robert Plant – brandendo il suo basso con un po’ di esibizionismo a cui non siamo abituati.
Gli strumentisti in alcuni momenti suonano con mano pesante; l’attacco di “Shine on you crazy diamond” e di “Wish you where here” fa storcere il naso ai puristi più intransigenti (quelli che proibirebbero ogni minima variante alle versioni insuperabili e sacre del disco); la voce di Waters viene supportata nei toni più alti da quella delle coriste e del chitarrista, denotando così un deficit che i fans non accettano e che fanno fatica a dover ammettere: ma sono aspetti tipici di un concerto suonato da esseri umani, e che per questo danno allo show una inaspettata dose di poeticità. Roger Waters, specie all’inizio, fa quasi tenerezza nel suo sforzo di rivendicare la paternità creativa di quei capolavori e di metterli in scena in un modo diverso (ma in fondo, poi, non troppo diverso, almeno musicalmente) dai modelli tradizionali.
I brani, a veder bene, sono sempre quelli, anche se spogliati dal costume tronfio, ingombrante e faraonico dell’epopea pinkfloydiana. Dopo l’entrata necessariamente caciarona e autocelebrativa di “In The Flesh” e “Another Brick in The Wall”, Waters procede inesorabilmente, nonostante tutto, e dimostrando che le critiche sono solo miseri dettagli, a fronte di sì tanta grandezza. Col momento acustico di “Mother” il pubblico si ravvede e improvvisamente capisce che cosa significa sentir cantare un brano del genere dalla voce dolce e unica al mondo di Waters, con una intensità e un’onestà artistica che Gilmour non può aver mai avuto. Ma l’unicità del concerto la si percepisce appieno non appena Roger intona “Pigs On The Wings” e “Dogs”, perle di quell’ “Animals” che i Floyd non hanno mai portato in scena e che la voce dell’interprete originario, unico e solo, rende luminose come non mai. Si avverte un primo momento di autentica commozione che si propaga nel pubblico dopo i fasti iniziali dello show. Calati ormai nella logica del concerto, i fans cominciano a rilassarsi e a farsi trasportare dalle atmosfere psichedeliche di “Set The Controls For The Heart Of The Sun”, tratto da “A Saucerful Of Secrets”, il secondo album dei Floyd, brano assolutamente inatteso, ma che doveva esserci, a testimonianza di un momento creativo irripetibile vissuto in quel lontano 1968. Il brano, infatti, suona attualissimo, come se fosse una composizione degli Spiritualized di oggi o dei tanti gruppi post psichedelici di questi anni.
Il concerto prende la piega giusta e Waters appare sereno e molto umano, anche nel concedersi al pubblico, col quale sembra voler creare uno scambio reciproco di emozioni di cui forse sentiva da tempo la mancanza. Si procede con “Breathe (In The Air)”, “On The Run” e “Time” , necessariamente ridimensionate nelle lunghe entrate che le caratterizzavano in “The Dark Side On The Moon”. “Shine On You Crazy Diamond”, “Wish You Where Here”, “Welcome To The Machine”, “Money”, seguono una dopo l’altra portando il pubblico tra le stelle, seppure con quella diversità e maggiore semplicità rispetto ai canoni tradizionali che ha caratterizzato tutto il concerto. Ma non ha più importanza cercare il pelo nell’uovo nelle esecuzioni non sempre impeccabili, se dotate comunque di tanta suggestione e intensità: è un concerto di emozioni forti, trasmesse da un uomo che si fa amare anche per i suoi limiti di oggi, e che anzi, forse per questo recupera una dose di simpatia e affetto negatagli dopo la scissione col gruppo. Il Roger Waters pazzo, nevrotico, antipatico, prevaricatore nelle scelte del suo ex gruppo, il musicista dipinto come l’anima fondamentale ma comunque distruttrice del gruppo, sembra completamente scomparso. Per la prima volta i fans gli perdonano di aver distrutto il sogno dei Pink Floyd, responsabilità pesante che per anni gli è stata addossata e che gli si addebita tuttora, oscurandolo immeritatamente.
L’approccio umano di stasera restituisce dignità ad un artista che candidamente vuole solo dimostrare l’universalità di quelle canzoni e ritrovare la felicità di suonarle. E’ questo approccio inedito, sorprendentemente “felice” alla sua musica, a rendergli finalmente giustizia. Grazie al ritrovato feeling col pubblico Waters può adesso permettersi perfino di riproporre altri brani della sua carriera, tutti splendidi, dolci e toccanti, dimostrando la sua purezza di artista e di compositore. Anche questa seconda parte dello show offre al pubblico l’occasione per rendersi conto che sta assistendo ad un evento difficilmente ripetibile. Addirittura ora Waters riesce perfino a dare dei punti ai suoi ex compagni, che mai sono stati capaci di comporre qualcosa di nuovo veramente valido, nonostante i mezzi illimitati di cui hanno potuto disporre e le produzioni stratosferiche costruite attorno a “The Momentary Lapse of Reason” e “The Division Bell”, dischi deboli, appena dignitosi, e comunque considerati pur sempre “dischi del dopo”. E’ il momento di “Perfect Sense”, “The Bravery Of Being Out Of Range”, “It’s A Miracle” e “Amused To Death”, brani passati inosservati nel decennio che ha visto la colpevolizzazione di Waters e che oggi ritrovano luce e respiro (anche con la nota antologia di recente pubblicazione).
Il finale non può che essere apoteotico, con una “Eclipse” impeccabile, una “Brain Damage” commovente e una conclusiva “Comfortably Numb” giustamente rumorosa, retorica e autocelebrativa (ma con un pubblico ormai in fiamme non poteva essere diversa).
Il bis richiesto è l’inedito “Flickering Flame”, giusto finale dolce e acustico per riequilibrare un concerto così carico di emotività, e per sedare gli animi.
I fans hanno visto forse per la prima volta Roger Waters sorridere, e andare esultante a raccogliere applausi sino agli angoli più remoti del palco, così tradendo quella serietà obbligatoria che si leggeva perennemente sui volti dei vari Gilmour, Wright e soci, imposta dalla gravità delle note liriche pinkfloydiane. Concerto imperdibile.
Giuseppe Basile © Geophonìe
